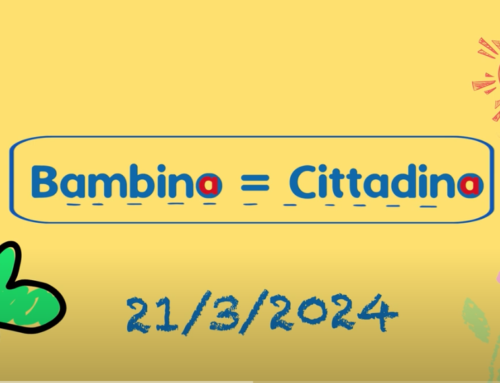“Docenti, a 45 anni sono già sfiancati. Miseria stipendiale. Studenti non sanno leggere? Superiori anello debole”.
“I ragazzi credono di sapere. I professori, da parte loro, pensano di essere all’angolo perché temono di non poter competere con la potenza dei mezzi e delle masse illimitate di informazioni. Così noi prof ci arrendiamo, i ragazzi credono di sapere e invece non sanno e allora non si mettono nell’atteggiamento della ricerca”
È il paradosso della nostra epoca: l’epoca della più grande raccolta di informazioni e di conoscenza è un’epoca che sembra coltivare l’ignoranza”.
Memi Campana è un docente di lungo corso, diciamo che è un ex professore, anzi un ex maestro, anzi entrambe le cose, visto che ha avuto a che fare per anni con i bambini delle scuole elementari, prima di diventare docente di Diritto ed economia alle superiori. Ma quale ignoranza?
“Siamo noi delle superiori – precisa – che non ci curiamo di questo stadio di crescita e rimproveriamo loro di non essere capaci, ma qui inganniamo noi stessi perché rimpoveriamo loro, mentre dovremmo essere noi a rafforzare e per così dire ricostituire queste capacità di scrittura e di lettura perché noi stessi siamo un po’ influenzati da ciò che rimproveriamo, noi stessi leggiamo meno. Rimproveriamo i ragazzi di non scrivere mentre già noi stessi non lo stiamo più facendo”.
E ancora: “Gli insegnanti sono stanchi. E’ una categoria stanca. A 45 anni sono sfiancati, c’è un lamentismo pervasivo che non va bene, che ci dice che dobbiamo cambiare. Se lamentarsi è la premessa per una richiesta di cambiamento e per un’analisi che serva ad approntare gli strumenti del cambiamento va bene. Altrimenti diventa un mantra, una specie di rumore di fondo, brusio, una pesantezza”.
È stato pure bidello, o meglio, operaio scolastico. Ma non lo si può definire neppure un ex della scuola. Poiché lui, Domenico Campana, modenese – da tutti conosciuto come Memi dacché la madre era di Venezia e Memi stava per Domenico – la scuola, che come tutti ha conosciuto prestissimo, non l’ha mai abbandonata, neppure ora che va verso i settanta, come non si abbandona mai qualcosa che sia entrato nella profondità del sangue.Campana fa parte del Movimento di Cooperazione Educativa e si sta battendo per l’approvazione della riforma della legge sulla cittadinanza che consenta a tanti bambini e ragazzi che frequentano le nostre scuole di diventare cittadini a tutti gli effetti. “In 30 anni – dice – l’Italia è diventato un paese a forte immigrazione e in questo contesto ci sono tanti ragazzi, circa un milione e mezzo, che o sono nati in italia o sono arrivati dopo che però sono nelle nostre scuole: è una anomalia, si tratta di riconoscere una situazione di fatto. Quando un bambino cresce in un ambiente economico, spaziale, sociale culturale, e diventa parte integrante delle condizioni di vita di quel posto, non avere la cittadinanza lo penalizza: dalla gita in Francia, all’accesso a una società sportiva, tanto per fare alcuni esempi pratici”.
Professor Memi, Campana, la scuola le entra nel sangue, da ausiliario scolastico, negli anni del fermento giovanile
“Ero operaio comunale, negli anni ‘75 e ’80, prima che nel 1988 diventassi insegnante di Diritto ed Economia alle superiori. Il Comune di Modena aveva all’epoca istituito il doposcuola che poi si trasformò nel tempo pieno. Era l’epoca in cui si costruivano le scuole dell’infanzia, che allora si chiamavano scuole materne. La spinta alla scolarizzazione piena fece sì che il Comune di Modena avesse bisogno di personale nelle materne e nel tempo pieno delle elementari. Serviva personale ausiliario, anche perché erano gli anni in cui durante l’estate partivano i centri estivi e i soggiorni montani e marini. Serviva gente sveglia, donne e anche uomini. Io mi stavo laureando in Scienze politiche all’istituto Economico di Bologna, fondato da Nino Andreatta, un luogo dove insegnava gente come il professor Romano Prodi e vari insegnanti di altissimo livello. Mentre stavo studiando feci domanda per fare l’ausiloiario nelle scuole modenesi”.
Come ricorda oggi quell’esperienza?
“E’ stata un’esperienza molto bella, perché era un momento di grandissima crescita culturale e pedogogica. Il Comune di Modena attraverso figure importanti come il pedagogista Sergio Neri e l’assessore Liliano Famigli, esponente importante del Partito comunista, puntò sulla crescita delle nuove generazioni. Il partito non intendeva ideologizzarle ma spingeva molto per una crescita culturale italiana: in Emilia il Pci capiva l’importanza che anche gli operai fossero colti. A Modena fu il Pci a inventare l’Istituto tecnico industriale provinciale E. Fermi (ancora oggi le ricerche Eduscopio della Fondazione Agnelli danno il “Fermi” di Modena tra le prime in classifica a livello nazionale sul piano dell’occupabilità e delle performances universitarie dei suoi studenti, ndr). Vivevamo il momento della forte industrializzazione del nostro Paese, qui a Modena, con i nascenti distretti industriali. C’era bisogno da un lato di avere degli operai colti e non solo esperti. Dall’altro lato si puntò sull’occupazione femminile: se tu i bambini puoi metterli ai nidi e alle elementari anche al pomeriggio permetti alle donne di esprimere la propria potenzialità di donne e lavoratrici. E io mi sono sentito, a venti, trent’anni, in piena sintonia con questa crescita delle nuove generazioni. La mia generazione e le prime generazioni del Dopoguerra erano le generazioni del ’68. Percepimmo che eravamo in un momento di svolta. E la svolta era la cultura, una cultura emancipativa che intendeva far sì che non soltanto gli operai fossero più ricchi ma che avessero nelle proprie mani la propria capacità progettuale”.
Ed era l’epoca della forte immigrazione, nella sua Emilia, dal Sud Italia
“Allora c’erano qui a Modena, come in altre città del Nord, tantissimi operai e famiglie meridionali appena arrivate per lavorare, tante donne che venivano dal Sud potevano trovare un’occupazione. La mia esperienza all’interno delle scuole come operaio mi dava l’opportunità di fermarmi due ore con loro perché sentivo un grande interesse per la crescita e per l’apprendimento infantile e anche per la crescita cognitiva dei ragazzi e, di riflesso, di tutti noi esseri umani. E quindi ho avuto la possibilità di lavorare attento a questi processi nei nidi d’infanzia e alle elementari e dunque di avere visione e contatto con la crescita umana dei bambini zero-dieci anni. Anche attraverso i soggiorni estivi, dove c’erano ragazzi fino a 15 anni, ho avuto davanti a me un arco di vita da zero a 15 anni che mi ha permesso di raggiungere e sviluppare una certa capacità di ascolto di questa generazione”.
E’ vero che dopo aver letto la Lettera a una professoressa lei preparò lo zaino per andare a trovare Don Milani? Che però era morto da un po’ di tempo. Quanto è stato importante per lei incontrare Don Lorenzo Milani?
“Grazie della domanda. Ho avuto la “Lettera a una professoressa” da mio fratello Bepi a settembre 1967. Avevo 16 anni, avevo preparato lo zaino per andare a trovare don Milani, ero entusiasta. Poi mio fratello mi informò che era morto. Don Milano mi ha aperto la testa. Un ramo della mia famiglia era contadino. Io vedevo i bambini dei contadini che andavano a scuola ma erano figli di un Dio minore dal punto di vista della scuola perché ancora pesavano cose concrete. Era nata da poco la scuola media unificata, io sono stato l’ultimo a fare la media tradizionale, e quando frequentavo la quinta elementare si doveva ancora scegliere se andare alle scuole di avviamento o alle medie che avrebbero dato poi accesso alle superiori e all’università e quindi era chiaro che i figli di operai e contadini avrebbero intrapreso l’avviamento professionale. La legge del 1963 ha superato questa barriera, c’è stata la liberalizzazione dell’accesso all’università dove prima si accedeva solo con il liceo classico e ad alcune facoltà scientifiche anche facendo l’istituto tecnico industriale. I figli degli operai, quindi, o sceglievano l’avviamento professionale oppure andavano all’Iti “Corni” di Modena e in alcuni casi proseguivano all’università. Ma il grosso degli universitari proveniva da famiglie di estrazione borghese o colte, come quella di mio padre, che insegnava. La mia lettura della Lettera si inserisce in questo contesto di desiderio di emancipazione della vita degli operai. Io, come tanti ragazzi, lavoravo d’estate, portavo l’acqua minerale nelle fabbriche. Una volta andai in una fabbrica tessile vicino a Modena. Vi lavoravano molte ragazze dai 14 ai 16 anni che avevano la mia età e tutte dicevano di dovere stare zitte sul posto di lavoro. Una mi disse: non possiamo parlare nemmeno tra noi, il padrone ha licenziato una di noi perché rideva. Quella cosa mi ha cambiato la vita. Io mi sono detto: ma queste ragazze chi le difende? La Lettera mi ha dato consapevolezza della necessità che fosse raggiunta l’emancipazione: ci fu in me uno slancio adolescenziale di ribellione”.
Dal silenzio alla parola. Lei ama sottolineare l’importanza della parola
“La Lettera e lo sguardo di emancipazione di Milani non era solo di carattere economico, era soprattutto di carattere culturale attraverso il possesso della lingua. Siamo andati nel ‘69 a Firenze per incontrare gli allievi di Milani nell’intento di fare un doposcuola a Modena sulla scorta della sua esperienza, che poi facemmo immediatamente. Nel caso mio essere a contatto con i ragazzi ha coinciso con una specie di vocazione e inclinazione profonda verso la crescita umana e la scuola. Quella cosa mi ha aiutato ad aderire al ’68, non solo sul piano economico ma soprattutto sulla padronanza di sé e dei progetti di vita che si ottengono solo con la padronanza della parola e con la conoscenza delle cose della vita. Quanto a me, devo a Milani il dispiacere di non essere il più delle volte in grado, nelle scuole reali, di portare tutti i giovani che hanno la ventura di avermi maestro e prof al livello di conoscenza cui avrebbero diritto. Tutti. Non uno di meno. E ogni volta alla fine dell’anno un sottile senso di vergogna mi morde, a volte per ciò in cui sono stato carente io, sempre per ciò in cui è carente la scuola”.
I suoi primi anni della scuola erano gli anni delle assemblee. L’assemblea è oggi la grande assente dall’edificio scolastico
“La forma assembleare di discussione tra pari è quella che assicura la massima espressione della parola pubblica della quale i ragazzi hanno un bisogno vitale. Il suo mancato esercizio comporta una grave limitazione della crescita civile dei ragazzi. Invece di vedere un film dovrebbero dibattere, confrontarsi, anche litigare. Ai nostri tempi partivano alle 9 di mattina e finivano alle 9 di mattina”.
Da un po’ di tempo i giovani studenti vengono accusati di essere piuttosto ignoranti, addirittura di avere difficoltà nella comprensione di un testo. Eppure le opportunità di conoscenza sono oggi quasi illimitate, a differenza del passato.
“Io penso che da un lato la diffusione delle tecnologie fa sì che i giovani possano accedere alle conoscenze in una misura più ampia rispetto a quanto non succedesse alla nostra generazione ma nello stesso tempo con minore capacità di organizzare questa conoscenza, perché essa si presenta in maniera confusa e disordinata, mentre noi quel poco o molto di quel che sapevamo derivava da un progetto di conoscenza. Noi avevamo un progetto di conoscenza: voglio sapere questo – ci dicevamo – e dunque vado in biblioteca, oppure da qualcuno che ne sa, in associazione, nelle sezioni di partito. Oggi con un clic si ha l’impressione di sapere: in realtà manca un principio ordinatore, ma soprattutto manca uno spazio in cui apprendere dei principi che ordinino la ricerca, dei principi di carattere morale, etico, che facciano capire perché sia importante studiare. Parrocchie e sezioni erano luoghi di confronto che ora mancano. Questi centri ordinatori non ci sono ma non bisogna certo tornare indietro. E, soprattutto, dovrebbe essere la scuola a rappresentare uno spazio di elaborazione e apprendimento e ricerca delle inclinazioni personali eppure la scuola arranca su questo. Anche noi professori siamo delle borse (persone noiose, in gergo modenese, ndr). Gli insegnanti negli ultimi 20 anni hanno fatto fatica a rappresentare questo spazio culturale in presenza di un’enorme mole di tecnologia, di social. Noi prof rappresentavamo un tempo l’80 per cento del sapere dei ragazzi, la restante parte era rappresentata dalle parrocchie, dalle sezioni, dalla famiglia. Ora noi insegnanti rappresentiamo una frazione delle potenzialità conoscitive che i ragazzi hanno a disposizione con il tocco di un dito. I prof pensano di essere all’angolo perché pensano di non poter competere con la potenza dei mezzi tecnologici e con la mole illimitata di informazioni. Così noi insegnanti ci arrendiamo, i ragazzi credono di sapere e invece non sanno e allora non si mettono nell’atteggiamento della ricerca E’ il paradosso della nostra epoca: l’epoca della più grande raccolta di informazioni e di conoscenza è un’epoca che sembra coltivare l’ignoranza. Del resto, certe manifestazioni in qualche modo legate alla pandemia ce lo hanno dimostrato: da un lato abbiamo una grande valorizzazione della scienza, ma nello stesso tempo sono cresciuti gli irrazionalisimi e le superstizioni”.
Di che cosa ha bisogno la scuola?
“C’è un pregiudizio da parte delle università verso la scuola. C’è un ritorno all’idea che avere aperto la scuola a tutti sia stato un errore. Lo slogan è che lo studio non sia per tutti. C’è un ritorno a un atteggiamento regressivo che tende a dare la colpa all’art 34 della Costituzione che, diciamolo, sta sulle scatole a tanti. Danno la colpa a noi di avere attuato il dettato costituzionale, invece la scuola rappresenta un presidio culturale laico, repubblicano, democratico. Senza nascondere la necessità che gli insegnanti debbano essere messi nelle condizione di insegnare. Trenta alunni per classe andrebbe anche bene ma le condizioni sono la formazione, la stabilità, un rapporto ottimale alunni-docenti. Si rimprovera ai ragazzi che si affacciano all’università che non sanno leggere e scrivere. Allora vuol dire che alle elementari non insegnano a leggere. Ma chi fa questo discorso – gli universitari – non sa che è pur vero che si impara tra i 6 e i 10 anni, ma è vero anche che si impara altrettanto o forse di più dai 14 ai 17 anni, perché è un momento dello sviluppo affettivo e antropologico dei ragazzi che chiede loro di avere degli strumenti espressivi adeguati, è una fase in cui sviluppano sé stessi. C’è in quella fase non soltanto una metamorfosi delle proprie capacità cognitive ed emozionali, è il momento in cui le capacità di lettura e di scrittura devono ricostituirsi. Ed è lì l’anello debole: siamo noi delle superiori che non ci curiamo di questo stadio di crescita e rimproveriamo loro di non essere capaci, ma qui inganniamo noi stessi perché rimpoveriamo loro, mentre dovremmo essere noi a rafforzare e per così dire ricostituire queste capacità di scrittura e di lettura perché noi stessi siamo un po’ influenzati da ciò che rimproveriamo, noi stessi leggiamo meno. Rimproveriamo i ragazzi di non scrivere mentre già noi stessi non lo stiamo più facendo: anche la cultura degli insegnanti è sottoposta a una forma di stanchezza culturale, c’è una minore vivacità. Quando arrivano da noi dei ragazzi e delle ragazze di 14 anni non bisognerebbe tanto pretendere da loro una piena capacità espressiva, quanto piuttosto partire dal bagaglio che hanno e rifare la strada della lettura e della scrittura partendo dalle loro capacità dando loro la mano a esprimere i propri bisogni che sono bisogni infantili. La lettura e la scrittura bisogna impararle alle superiori”.
E questo non succede?
“Ogni tanto sì, spesso no. Si sente dire: non sono scolarizzati. Si dice che alla primaria non si boccia. Paradossalmente le elementari italiane sono state il livello più avanzato del mondo, una vera eccellenza mondiale. Gli insegnanti sono stanchi. E’ una categoria stanca. A 45 anni sono sfiancati, c’è un lamentismo pervasivo che non va bene, che ci dice che dobbiamo cambiare. Se lamentarsi è la premessa per una richiesta di cambiamento e un’analisi per approntare gli strumenti del cambiamento va bene, altrimenti diventa un mantra, una specie di rumore di fondo, un brusio, che è una pesantezza”.
E c’è una emergenza salariale, riconosciuta, almeno a parole, anche dal mondo politico
“Si accompagna a tutto il resto. Segnalerei che la miseria stipendiale degli insegnanti italiani, che è anche sotto alla media dei colleghi europei, ci dice che c’è una questione salariale, però ci dice anche che l’intera filiera della formazione degli insegnanti va riformata. Tullio De Mauro aveva previsto il riordino dei cicli e aveva proposto un aumento consistente che accompagnasse una riforma dei cicli e una riforma della professionalità dei docenti: eliminare le medie e fare una primaria e una secondaria con un sette più cinque per finire un anno prima e una riforma dell’accesso universitario. Tu, Stato, devi dare dei soldi agli insegnanti della scuola pubblica e non puoi darglieli domani: lo devi fare oggi, accompagnando l’aumento dello stipendio con una riforma condivisa dei cicli e della formazione”.
Di